Eugenio Montale
Un doppio anniversario
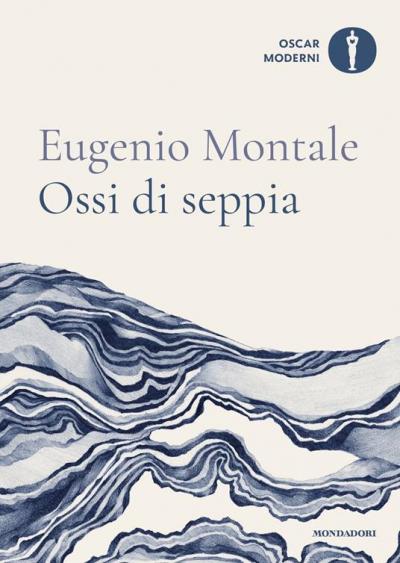
Eugenio Montale (12 ottobre 1896-12 settembre 1981) pubblicò Ossi di seppia a ventotto anni giusto un secolo fa, nel 1925, a Torino con la casa editrice di Piero Gobetti. Quest’ultimo, nato nel 1901, era ancora più giovane di lui, già perseguitato dal fascismo (sarebbe morto nel febbraio dell’anno dopo a Parigi dove si era rifugiato in seguito a una serie di aggressioni), già disilluso in campo letterario: “Caro Montale, le sue poesie mi piacciono” -gli scrisse- anche se, “per un volume di eccezione e di gusto come il suo”, troveranno “in Italia uno scarso pubblico”. Il poeta gli era stato presentato qualche anno prima dal torinese Sergio Solmi, anche lui poeta e critico letterario, che con Montale aveva condiviso il servizio militare a Parma: un’esperienza che li avrebbe segnati profondamente e da cui sarebbe scaturita una lunga amicizia.
Congedato dall’esercito dopo la prima guerra mondiale, il giovane Montale si era trovato ad accettare con fatica la prospettiva di un impiego fisso come ragioniere. Pur continuando a coltivare la passione per il canto lirico -era un aspirante baritono- aveva tentato di aprirsi una strada come giornalista e come poeta, facendo pubblicare i suoi versi – i primi risalivano al 1916 – sulle riviste letterarie.
Il 1925 è lo stesso anno in cui aderisce al manifesto antifascista. Ma non ama esporsi politicamente più di tanto (“la rivoluzione son disposto a farla tutti i giorni dentro di me; ma fuori preferisco non bere olio di ricino o buscare legnate”). A differenza del suo attivissimo editore torinese, che guarda con ammirazione, la sua è – per sua stessa ammissione- una vita “al cinque per cento” che si colloca tra “chi rimane a terra”, “chi non sa volare” (cfr. Eugenio Montale, Sergio Solmi, Ciò che è nostro non ci sarà tolto mai. Carteggio 1918-1980, Quodlibet, 2021).
Frequenta però con assiduità gli ambienti letterari più vivaci del primo Novecento. A Genova diventa amico di Bobi Bazlen arrivato da Trieste nel 1923, grande lettore e critico dal fiuto straordinario che lavora in una ditta d’importazione di caffè. Fu lui uno dei primi estimatori dei suoi versi, quello che gli procurerà, tra gli amici triestini, molte delle sottoscrizioni necessarie alla prima pubblicazione di Ossi di seppia. Dal 1928 si sposterà poi a Firenze con diversi soggiorni a Trieste dove conoscerà Gillo Dorfles, Umberto Saba e Giani Stuparich.
Fu dietro sollecitazione di Bazlen che Montale conobbe le opere di Franz Kafka e ne promosse la traduzione in italiano da parte di Giuseppe Menassé, un ebreo di origine turca. Sempre grazie a Bobi Bazlen Montale apprezzò Italo Svevo e lo fece conoscere in Italia pubblicando un articolo sulla rivista Solaria nel 1925. Italo Svevo a sua volta metterà in contatto Montale con l’ambiente parigino, quello che all’epoca era il centro nevralgico della cultura europea, mentre Mario Praz gli aprirà le porte del mondo anglosassone.
La cultura europea lo attrae: “pur così saturo di cultura nazionale, è internazionale per indole, non solo per caratura” (cfr. Gianluigi Simonetti, Gli occhi asciutti di Montale … in Tuttolibri 18 gennaio 2025).
Quest’anno cade anche il cinquantesimo anniversario del premio Nobel per la letteratura conferito a Eugenio Montale nel 1975. A distanza di tanti anni la sua consacrazione nel Novecento letterario, insieme a Giuseppe Ungaretti, si rivela tra le più durature:
“Hanno in effetti ammazzato il tempo, Ungaretti & Montale, uniti in una felice sorte postuma, pur essendosi poco amati da vivi”. (Paolo Di Paolo, Rimembri ancora, Il mulino, 2024)
Perché leggere oggi Ossi di seppia?
“Ecco Montale disincantato da sempre. No, non pessimista. Forse privo di fiducia, come Leopardi, nelle ‘magnifiche sorti e progressive’ ma non tragico né apocalittico. Uno che spera nel meglio, ma vede le cose ad occhi aperti” (Paolo Di Paolo, cit.)
"I suoi sono “versi da rileggere, più che da leggere; sono invecchiati poco o nulla, perché erano fatti per durare. Semmai siamo invecchiati noi lettori, distratti dal tempo che manca, dall’assenza di concentrazione e soprattutto dal rumore circostante. Chissà se siamo ancora in grado di meritarla, di sopportarla, di capirla, questa strana musica” (Gianluigi Simonetti, cit.)
La raccolta Ossi di seppia, dopo la prima edizione del 1925, venne riedita diverse volte, tra le tante, da Einaudi nel 1942, con molte ristampe. Dal 1948 fu pubblicata da Mondadori. E’ del 2024 la prima edizione Oscar Moderni, con uno scritto, da non perdere, di Giuseppe Montesano.
PFM


