Trent’anni dal genocidio di Srebrenica
Dove iniziò il Duemila
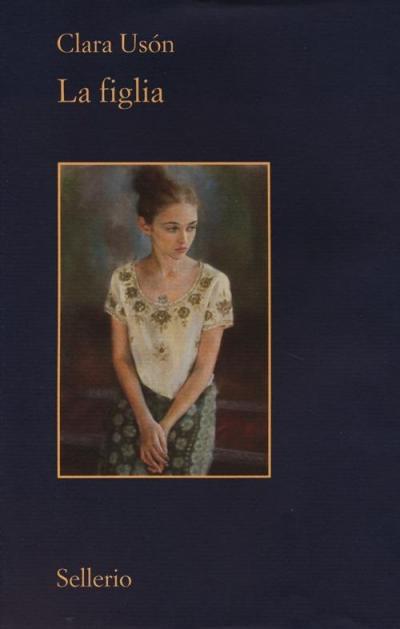
L’11 luglio l’ONU ha istituito una Giornata internazionale per ricordare il genocidio di Srebrenica avvenuto nei territori dell’ex Jugoslavia.
Era il 1995, il terzo anno di una guerra che l’opinione pubblica europea aveva percepito fin dal primo momento come periferica: un conflitto tra serbi, croati e bosniaci musulmani che, per la forte componente identitaria, etnica e religiosa, sembrava appartenere a un’altra dimensione non solo spaziale ma temporale. Una guerra medievale, si pensò.
In quella circostanza le organizzazioni internazionali mostrarono per la prima volta tutta la loro debolezza.
Il 10 luglio a Srebrenica, nella Bosnia orientale, le Nazioni Unite ordinarono a militari e civili di consegnare le armi dichiarando la zona come territorio “demilitarizzato”. Il giorno dopo bande cetniche arrivarono in città e selezionarono tutti gli uomini dai diciassette ai settant’anni, senza che nessuno dei caschi blu olandesi tentasse alcuna forma di opposizione.
Li caricarono su dei pulman, li portarono nei boschi circostanti e li massacrarono sistematicamente uno ad uno, gettando i corpi in fosse comuni alcune delle quali sono ancora da individuare. I morti accertati furono 8.372. Secondo il Tribunale penale dell’Aja si trattò di un “genocidio”.
Qualcuno ritiene che da questa strage prenda le mosse anche la crisi che sta investendo l’Europa: “Nulla racconta meglio il presente. L’ipocrisia, la mistificazione dei fatti. (...) Fu un’anticipazione del mondo attuale” con tutte le sue divisioni e la sua violenza. (cfr. Niccolò Zancan, I morti sospesi di Srebrenica, La stampa 10 luglio 2025).
Ricordiamo queste tragiche circostanze leggendo tre romanzi molto diversi tra loro che riguardano la guerra nell’ex Jugoslavia:
Clara Usón, La figlia (Sellerio)
Una figlia amata, con un futuro brillante davanti a sé, scopre casualmente che l’adorato padre viene chiamato il Boia dei Balcani. Si tratta di Ratko Mladic, responsabile dell’assedio di Sarajevo, della pulizia etnica in Bosnia, del massacro di Srebrenica. “E’ una perdita dell’innocenza, individuale e collettiva” quella che viene raccontata nel libro. Una miscela di indagine e narrazione che fa riflettere sulla malvagità umana, sulle conseguenze del nazionalismo esasperato e sugli effetti manipolatori della propaganda.
Elvira Mujcic, La buona condotta (Crocetti)
E’ un romanzo ambientato all’indomani dell’indipendenza del Kosovo. Si deve votare per il sindaco. Gli albanesi sono la maggioranza ma viene eletto un serbo. E’ un serbo che vuole andare d’accordo con gli albanesi. Ma a Belgrado non sono d’accordo e mandano un nuovo sindaco che continui a soffiare sul fuoco della rivalità etnica.
Elvira Mujcic, nata nel 1980 in Jugoslavia vive a Roma e usa l’italiano per scrivere i suoi romanzi.
Federica Manzon, Alma (Feltrinelli) (Premio Campiello 2024)
Alma torna a Trieste, città da cui è fuggita, per riceverne l’eredità paterna. Scopre che suo padre non era stato solo un amico di Tito e che Vili, figlio di due amici di Belgrado, con cui ha condiviso l’infanzia nella stessa casa, ha una vita piena di misteri. Un romanzo su Trieste, città di confine divisa tra i fasti della Mitteleuropa e le fiamme troppo vicine dei Balcani.
PM


